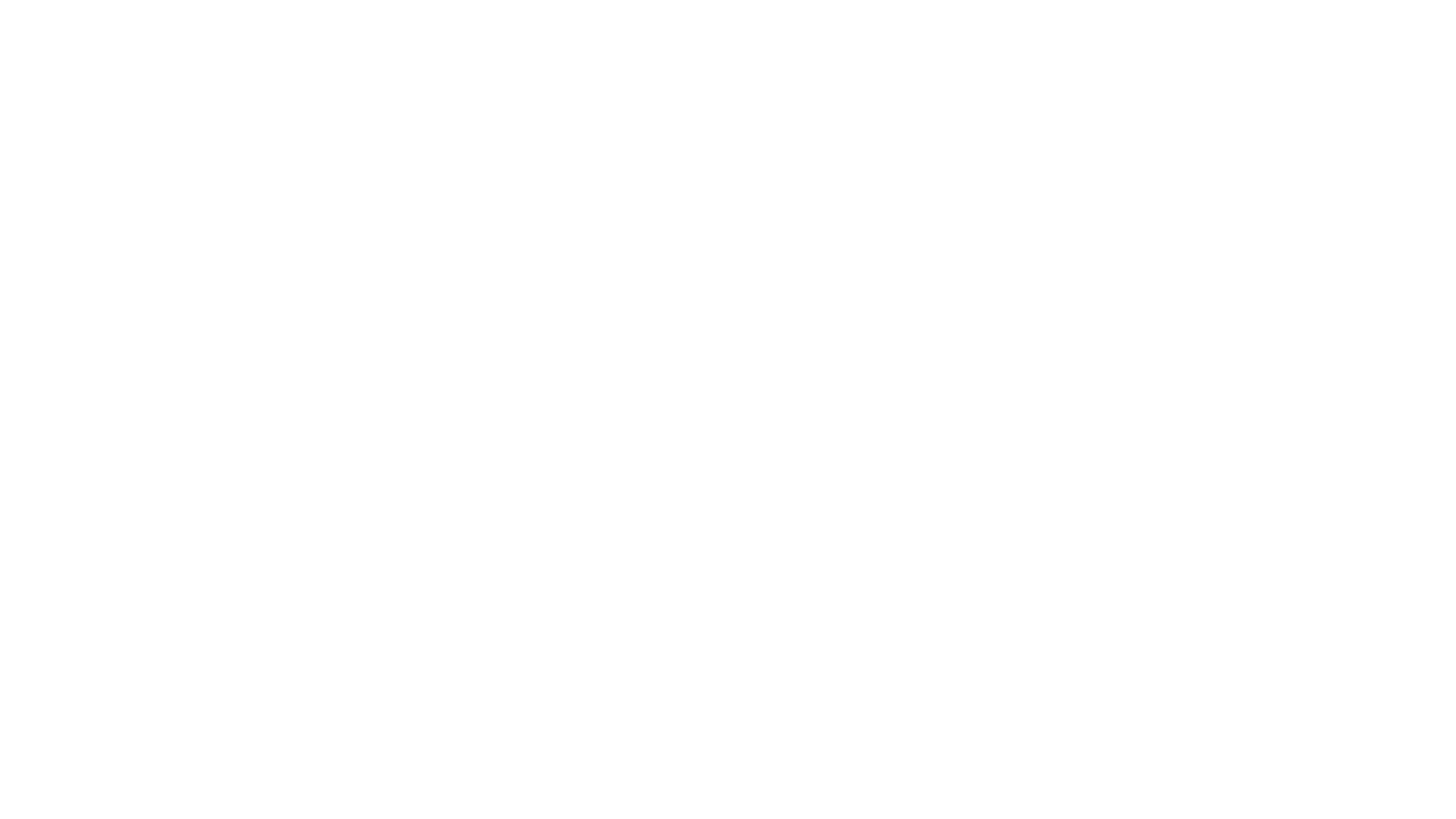Pinturas: ritratti di uomini normali e straordinarie imprese.
El diamante negro nasce in una sera di marzo del 1980, al Monumental di Buenos Aires, dove si sfidano per il primo turno a gironi della Copa Libertadores i padroni di casa del River Plate e i peruviani del Club Sporting Cristal. La partita prende una piega imprevista nei primi 45 minuti: i favoritissimi argentini sono sotto di due gol contro La Maquina Celeste, una sorta di Juventus del Perù, e un giocatore in particolare richiama l’attenzione del pubblico e dei giornalisti presenti, non tanto per il gol segnato, ma soprattutto per le qualità tecniche.
Il suo nome è Julio Cesar Uribe. Il River Plate ribalterà la gara, ma il nome di quel numero dieci inizia a varcare i confini nazionali.
Da quella sera l’uomo di punta del Cristàl sarà per tutti il diamante nero, così lo definirono i giornali di Buenos Aires, lui che aveva trascinato nel 1979 la sua squadra alla vittoria del campionato e che si ripeterà quello stesso anno, ovvero il 1980: una doppietta storica per la compagine peruviana.
C’è una giocata che caratterizza Uribe, inventata dal brasiliano Sergio Echigo, resa celebre da un altro verdeoro come Rivelino e marchio di fabbrica del diamante nero: l‘elastico, la elastica o la cuchara in Perù, quel gioco di gambe con il pallone incollato al piede che disorienta l’avversario trasformandosi in un dribbling da lasciare a bocca aperta chi lo guarda. Elastico, gol, assist, dominio assoluto del pallone: Uribe diventa un’icona non solo per i tifosi del Cristàl, non solo per quelli di una nazionale che raggiungerà anche grazie a lui i Mondiali del 1982, ma per tutto il Sudamerica.
1981, anno che precede il Mundial spagnolo. Maradona, Zico e lui, Julio Cesar Uribe: questo recita la classifica del pallone d’oro sudamericano, davanti al Diamante nero solo due grandissimi, quello che sarà il Dio degli argentini e Arthur Antunes Coimbra. Quando l’Italia di Bearzot affronterà il Perù nella prima fase della Coppa del Mondo l’allenatore italiano avrà un solo pensiero nella mente: come poter fermare Uribe, tanto da definirlo “temibilissimo, all’altezza di Maradona”. In quella competizione la nazionale peruviana verrà fermata da due pareggi e una sconfitta. Fuori al primo turno, ma le prestazioni di Julio Cesar non passano inosservate e, mentre Maradona va a Barcellona e Zico, dopo un altro anno al Flamengo, andrà all’Udinese, per Uribe si aprono subito le porte della Serie A.
Le cronache dell’epoca ricordano di un interesse della Roma: gli stranieri in Italia sono due per ogni squadra, i giallorossi hanno già tra le loro fila Falcao e acquistano l’austriaco Prohaska. Non tanto per scelta, quanto perché un’altra società ha usato tutti i mezzi a propria disposizione per poter avere Uribe: è il Cagliari di Amarugi, 140 milioni a stagione al ragazzo e soprattutto l’opera di convincimento di Gigi Riva.
L’allenatore del Cristal è un certo Alberto Gallardo, non uno qualunque, ma uno dei primi stranieri di peso della storia rossoblù e vecchio compagno di Riva. Fu acquistato dal Cagliari nel 1964 dal Milan, mandato in prestito biennale in rossoblù con le leggende dell’epoca che parlano di colossali bordate che, invece che finire dentro la rete dell’Amsicora, terminavano la propria corsa nell’attiguo canale di Terramaini, allora meno nobilmente noto come Mammarranca. Gallardo fu protagonista nel mondiali del 1970 quando il Perù fu sconfitto ai quarti dal Brasile di Pelè, e l’uomo di Leggiuno vola fino in Sudamerica per convincere Uribe ad accettare la corte del Cagliari anche grazie all’aiuto di quella vecchia conoscenza.
L’11 agosto del 1982, dopo una sosta a Fiumicino, Julio Cesar Uribe atterra in Sardegna accompagnato proprio da Gigi Riva. L’attesa è tanta, i rossoblù si sono assicurati un giocatore dal talento assoluto: lo stesso ex numero 11 dello scudetto lo definisce “di un altro pianeta” e “un Beccalossi molto più atletico”, insomma un endorsement non da poco. Quarto di sei fratelli – tre maschi e tre femmine – Uribe vive la gioia di un futuro in Europa, ma anche la nostalgia di una madre lontana migliaia di chilometri, che lo ha cresciuto praticamente da sola dopo che il padre l’aveva abbandonata quando lui era appena undicenne. Julio Cesar cresce nella povertà: non semplicemente quella “classica”, che spesso fa da cornice ai racconti che parlano di Sud America, ma ben oltre. E tra la passione per la boxe e quella per il calcio, l’Uribe adolescente sceglie il pallone, facendo una promessa a mamma Esperanza: grazie al calcio riuscirà a comprarle una casa.
Julio Cesar è talmente concentrato sul suo futuro, è talmente tanta la voglia di stupire la Serie A che prima di partire alla volta della Sardegna passa tre settimane sui libri a imparare l’italiano. Vuole arrivare pronto, non vuole lasciare nulla d’intentato e gli inizi sono confortanti. Quel numero 10 è davvero un diamante: il Cagliari non parte benissimo, ma Uribe fa comunque il suo e la squadra inizia a recuperare terreno al tramonto del 1982. La punta di diamante, ça va sans dire, è proprio lui, Julio Cesar Uribe, tanto da entrare di diritto nel miglior undici del girone d’andata ed essere considerato il miglior straniero del campionato fino a quel momento.
Eppure non è tutto rose e fiori in quel primo anno in Italia. Qualcosa di particolarmente brutto accade il 21 novembre, teatro il Bentegodi di Verona, decima giornata di campionato. A un certo punto del match il Cagliari conquista un calcio d’angolo e, come spesso accade, alla battuta ci va Uribe: i tifosi gialloblù, da qualche anno influenzati fortemente dal gemellaggio con gli hooligans londinesi del Chelsea, pensano bene di lanciare delle banane in direzione del giocatore peruviano. Il primo episodio di razzismo conclamato negli stadi italiani: Uribe ne è la vittima e poco conta che sarà proprio lui a segnare uno dei due gol dei rossoblù nel 2-2 finale, grazie a un colpo di testa e a un’uscita a vuoto di Garella.
Di reti ne realizzerà solo due in 20 partite: l’altra arriverà nella sconfitta per 3-1 a Firenze, tra qualche infortunio e quello che resta l’errore più grosso della sua vita. Non solo sportiva, come lui stesso ama sempre ricordare quando parla dei suoi tre anni in Sardegna.
Ci sono dei momenti nella vita in cui le scelte possono cambiare il destino in maniera irrevocabile. In quella di Uribe uno di questi bivi è sicuramente quello del 20 febbraio 1983, un giorno in cui non solo il futuro calcistico di Julio Cesar, ma anche quello del Cagliari prendono una direzione inaspettata. La squadra è in trasferta a Pisa, la salvezza è a portata di mano, il pericolo è sì dietro l’angolo, ma ci vorrebbe davvero tanto impegno per essere trascinati nel baratro: Uribe arriva da un infortunio, si sente pronto dopo le corse al Poetto per recuperare la forma migliore, ma l’allenatore Gustavo Giagnoni non la pensa come lui e gli preferisce un altro compagno.
Uribe ha un difetto, è tanto forte con i piedi quanto incapace di tacere, soprattutto se si sente vittima di un’ingiustizia: lui è il miglior straniero della Serie A, è nell’11 migliore del girone di andata, si sente più in forma di chi gli contende quella maglia, di andare in panchina non se ne parla. La decisione che cambierà il corso della stagione è rifiutare di sedersi in attesa di poter entrare in campo in corso d’opera, accomodandosi in tribuna di fianco al presidente Amarugi. Un vero e proprio atto di guerra, nemmeno le scuse del giorno dopo, quando il cuore ha lasciato spazio al cervello, serviranno a qualcosa. Nemmeno la cena offerta ai compagni, nulla.
Peraltro Uribe è amato dal pubblico, ma non particolarmente dalla stampa con cui paga l’associazione con un presidente mai amato, uno che davanti ai microfoni dichiarò che il suo errore fu proprio non difendere Julio Cesar, “oltre che un gran giocatore, patrimonio da un miliardo della società”. Se chi ne criticava la vicinanza all’odiato Amarugi avesse saputo il dietro le quinte, chissà, forse tutto sarebbe rientrato. Perché a Uribe il presidente servì su un piatto d’argento la testa di Giagnoni: se il numero dieci avesse detto sì il presidente si sarebbe sbarazzato del tecnico olbiese dopo quanto successo a Pisa. Invece Uribe decide che no, Giagnoni deve restare: ha chiesto scusa con il cuore e non per convenienza, l’uomo viene prima del calciatore e non avrebbe potuto sopportare di essere l’artefice del destino di un allenatore che lo ha messo in panchina ingiustamente, ma che è pur sempre un lavoratore come lui.
Così la stagione di Uribe e del Cagliari imbocca una discesa pericolosa: a fine anno nel match di Ascoli da dentro fuori dell’ultima giornata i rossoblù perdono due a zero, è Serie B. Julio Cesar va d’accordo con i compagni, anche se Marchetti, il centrocampista che gli gioca alle spalle, non gli perdona il deficit di mentalità, il non lottare per la sopravvivenza in Serie A e così anche il suo grande amico Gigi Piras, che lo definì un giocatore da grande squadra e non da battaglie di retrovia. Il destino, i bivi: ecco che forse quella corte della Roma sarebbe stata da accettare, giocare per traguardi più prestigiosi, correre meno e mostrare la propria tecnica. Magari con una scelta diversa sarebbe andato tutto diversamente, o se dopo la retrocessione fosse riuscito a farsi trasferire alla Juventus, o all’Inter, o al Milan o, ancora, alla Roma, che però alla fine scelse di andare su Toninho Cerezo.
Da campione a bidone è un attimo. È questione di fortuna, scelte e combinazioni che devono creare l’alchimia perfetta, ma nonostante tutto Uribe è sempre stato nel cuore dei cagliaritani e i cagliaritani nel suo. Anche se la squadra è retrocessa in quell’orribile 1983 lui è entrato a far parte – 24 anni dopo, nel 2007 – della hall of fame rossoblù anche grazie al suo carattere, alla sua umiltà e a quelle, poche, magie che ha mostrato in Sardegna.
La fine della sua esperienza a Cagliari arriva dopo due anni di Serie B. Il primo senza acuti, il secondo è quello dell’addio polemico: Veneranda licenziato dopo l’inizio pessimo, con Ulivieri che prende il suo posto, poi i primi punti grazie alla vittoria casalinga contro il Bari, con Uribe che segna il due a zero con un tiro da fuori area, ma il nuovo allenatore non lo vede e piano piano scivola in panchina. Un giorno vola per giocare con la nazionale e…non tornerà più da giocatore: a dicembre sembra in procinto di passare all’Universitario di Lima, nel frattempo Amarugi vende la società a Fausto Moi, ma il Cagliari non cede il Diamante nero per meno di 300 mila dollari. L’affare salta, ma alla fine arrivano i colombiani dello Junior Barranquilla e Uribe saluta definitivamente la maglia rossoblù dopo 69 presenze totali e 9 gol tra Serie A e Serie B, più 3 in Coppa Italia.
La frase di commiato, “Sì al calcio, no alla violenza”, racconta tanto dell’Uribe calciatore. Uno che non riusciva ad accettare di essere fermato con le cattive e che, probabilmente, non aveva dimenticato l’episodio di Verona. La nostalgia per la madre, tre anni di lontananza, come fattore determinante di un fallimento che si trasformerà, invece, in altri successi più vicino a casa: il campionato messicano vinto con l’America, altri due titoli con il suo Cristal, fino al 1994 quando appende le scarpette al chiodo e inizia la carriera da allenatore. Riuscirà ad allenare anche la nazionale, prima fra il 2000 e il 2002, poi nel 2007 per la Copa America, anche lì lasciando tra le polemiche per la convocazione del figlio Julio Edson e per una serata in discoteca in Giappone, dopo un’amichevole persa in terra nipponica.
Uribe non ha mai dimenticato Cagliari: il Diamante nero non ha espresso la sua luce in Italia, ma in Sud America sì, che il suo valore è sempre stato riconosciuto, tra quel terzo posto al pallone d’oro dietro due mostri sacri come Maradona e Zico e riconoscimenti importanti, come l’ordine al merito del calcio sudamericano conferitogli dalla Conmebol nel 2011 assieme a personaggi del calibro di Paco Maturana, Carlos Bilardo e il maestro Oscar Washington Tabarez. O, ancora, quel trono di miglior giocatore della storia del Perù da condividere con l’icona Teofilo Cubillas.
Tanti gol, assist, gli elastici, la nazionale, i bivi del destino: questa è la storia di Julio Cesar Uribe, il Diamante nero, ovvero uno dei giocatori più sottovalutati della storia del Cagliari.
Matteo Zizola