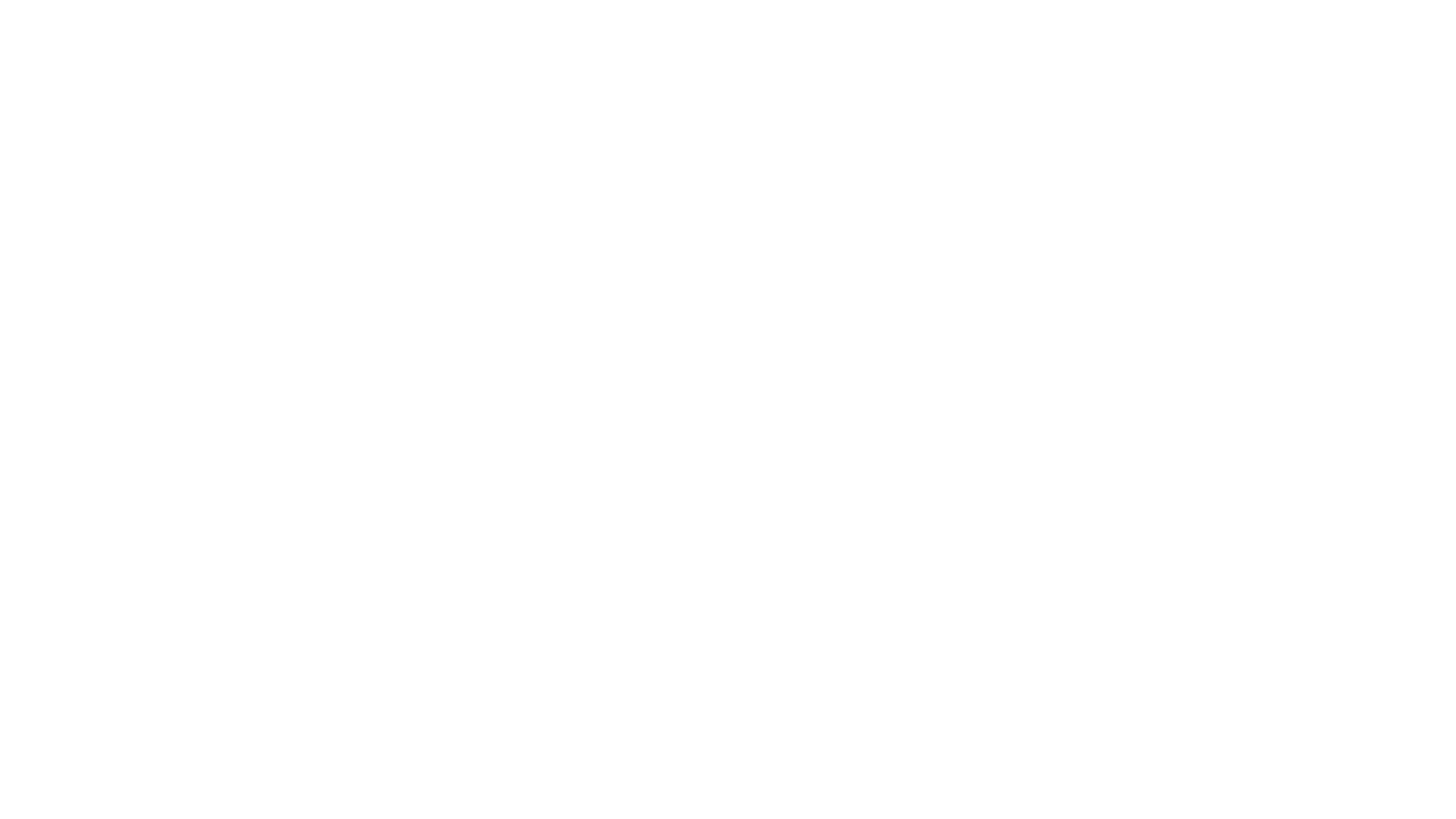Dall’Ogliastra al Missouri, passando dal settore giovanile del Cagliari. Abbiamo fatto due chiacchiere con Niccolò Cabras, portiere classe 2001 nato a Baunei e cresciuto nel vivaio rossoblù, che ci ha raccontato il suo percorso calcistico e universitario: dalle emozioni vissute con la Prima squadra cagliaritana alla sua avventura tra studio e sport negli Stati Uniti, nella “Central Methodist University” di Fayette.
Niccolò, iniziamo l’intervista dal tuo rapporto con il Cagliari. Quali sono i ricordi più belli del tuo periodo in rossoblù?
“Sono originario di Baunei, così quando a 14 anni sono entrato nel settore giovanile del Cagliari sono andato a vivere in convitto. È stata la prima volta che vivevo fuori casa ed è lì che ho iniziato a crescere. Con la classe 2001 abbiamo sempre raggiunto i playoff nazionali nei campionati Under 15, 16 e 17. Ho giocato con Andrea Carboni, Federico Marigosu e sono ancora in contatto con loro. Poi sono passato in Primavera con Canzi e, durante quel periodo, ho fatto anche una parentesi in Serie D all’Adriese. Sono tutti bei ricordi. All’età di 16 anni sono stato in panchina all’Olimpico di Roma in un Lazio-Cagliari finito 3-0 (22 ottobre 2017, ndr). Poi ci sono tanti altri momenti, come l’esordio in Primavera sotto età a Salerno nel 2017. Sceglierne uno è davvero difficile”.
C’è qualche allenatore o compagno di squadra del Cagliari che ha avuto un impatto particolare sulla tua carriera?
“Chi mi ha aiutato inizialmente è stata la coppia formata da mister David Suazo e il preparatore dei portieri Giuseppe Nioi. Suazo è stato il mio primo allenatore nel primo anno in Under 15 e poi l’ho ritrovato anche in Under 17, quando ero sotto età. Nioi mi ha fatto crescere tanto: venendo da un contesto piccolo come quello di Baunei, dove giocavo in un campionato provinciale, il cambio è stato molto difficile. Lui mi ha aiutato sin da subito, all’inizio anche con maniere un po’ ruvide. Solo dopo ho capito che erano proprio quelle di cui avevo bisogno”.
Chi è stato il compagno di squadra che ti ha impressionato di più?
“Carboni aveva fin da subito una qualità e una mentalità diverse. Poi, comunque, c’erano tanti altri della mia leva del 2001: Marigosu aveva una tecnica che, secondo me, era fuori categoria, e anche Daniele Cannas, il nostro bomber da venti gol all’anno. Poi, quando sono andato ad allenarmi in prima squadra e ho fatto il ritiro estivo, ho trovato giocatori come Nainggolan, Nández, Godín e Giovanni Simeone. Arrivavi lì e pensavi: ok, questo è il livello a cui devo arrivare. Non era facile, perché ogni allenamento era come una partita e dovevi sempre dimostrare qualcosa. Però, tra i ragazzi della mia età, su tutti spicca Andrea (Carboni, ndr)”.
Potresti raccontarci il tuo percorso calcistico, dalle tue prime esperienze fino al trasferimento negli Stati Uniti?
“Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 6-7 anni. All’inizio il calcio mi piaceva, giocavo fuori con gli amici, poi pian piano ho iniziato a giocare sempre di più. All’età di 12-13 anni ero già fisicamente ben messo, forse già alto come adesso e questo mi ha aiutato a spostarmi in porta. Quando avevo 14 anni, sono stato selezionato dal Cagliari e mi sono trasferito lì, dove ho giocato fino ai 18 anni. Poi nel 2019 c’è stata la parentesi in prestito in Veneto all’Adriese, dove ho disputato il campionato di Serie D poi interrotto dal Covid. Dopo quell’anno il Cagliari ha deciso di riportarmi in Sardegna per un’altra stagione. Ho fatto tutta la preparazione ed ero sempre in prima squadra, dato che il campionato Primavera era bloccato. A gennaio, però, volevo capire le intenzioni del club e sono andato all’Olbia in Serie C, dove ho ritrovato Max Canzi, una figura importante per me già negli anni in Primavera. A Olbia sono entrato in un contesto di alto livello, con un portiere esperto come Paolo Tornaghi, che giocava sempre e che aveva avuto anche lui un’esperienza negli Stati Uniti. In quella stagione ho esordito nell’ultima giornata di Serie C, ma a fine campionato mi sono ritrovato svincolato. A quel punto ho iniziato a pensare a un futuro diverso. Era strano, perché dopo una buona stagione in Serie D, un anno in prima squadra al Cagliari e un esordio in Serie C, a vent’anni avevo poco mercato. Per via della regola dei fuori quota, ero considerato ‘vecchio’ e questa cosa mi infastidiva parecchio. Mi sono quindi ritrovato in Valle d’Aosta (al PDHAE, ndr), dove ho disputato una buona stagione, nonostante avessi iniziato la preparazione solo a ottobre. L’anno successivo avevo deciso di rimanere lì, ma mi sono infortunato a un dito e ho dovuto operarmi, restando fermo per quattro mesi. Durante quel periodo ho iniziato a riflettere su un futuro diverso dalla carriera del calciatore professionista, cominciando a pensare al trasferimento in America. Negli Stati Uniti ti danno una seconda opportunità: ci sono molti coach che cercano profili europei per alzare il livello delle squadre dei college, offrendo così la possibilità di giocare in campionati molto competitivi. Una figura fondamentale per la mia partenza in America è stata Alessandro Marongiu, anche lui ex centrocampista del Cagliari Primavera. Ci sentiamo spesso, e il suo supporto è stato davvero prezioso. Tutto è iniziato dopo aver partecipato a dei provini a Novara, dove erano presenti osservatori di 20 università americane. Da lì hanno cominciato ad arrivare diverse offerte e ho dovuto scegliere la migliore per me sia dal punto di vista accademico che calcistico: la Central Methodist University di Fayette nel Missouri. La decisione non si basa solo sulle tue capacità sportive, ma anche sul tuo rendimento scolastico. Qui, infatti, sei uno studente-atleta a tutti gli effetti, e devi eccellere in entrambi gli ambiti: dentro il campo e in aula”.
Quali sono state le tue prime impressioni sul calcio americano rispetto al calcio italiano? Quali differenze hai trovato nello stile di gioco, nei ritmi e negli allenamenti?
“Sicuramente curiosità e novità. Quando sono arrivato non sapevo bene come funzionasse il sistema. Sapevo che la stagione fosse breve, di circa 3-4 mesi. Sono arrivato a Fayette la prima settimana di agosto 2023 e ho iniziato subito la preparazione. La struttura del campionato prevede 6-7 partite di pre-season che, pur essendo considerate amichevoli, sono fondamentali per determinare il ranking nazionale. È importante fare bene fin da subito. Successivamente inizia la Conference, un mini campionato di 12 partite: al termine si disputa un torneo che permette alle squadre di qualificarsi per le fasi nazionali. Chi vince il campionato accede direttamente al torneo nazionale. La mia lega universitaria comprende circa 300 università che competono in tutta l’America. Le differenze principali rispetto al calcio italiano sono notevoli. Ad esempio, qui si utilizza il tempo effettivo: il cronometro si ferma per infortuni, sostituzioni o altre interruzioni, mantenendo così un’intensità molto alta per tutti i 90 minuti. Inoltre, i cambi sono illimitati: un giocatore può uscire e poi rientrare in campo, cosa che contribuisce a tenere alto il ritmo. Dal punto di vista tattico, il calcio americano è meno organizzato rispetto a quello europeo. I coach stanno cercando di avvicinarsi agli standard europei, ma c’è ancora una grande differenza. Un’altra particolarità è la gestione del tempo di gioco: il cronometro parte da 45 minuti e scende a 0, e alla fine suona una sirena, come accade in NBA. Gli allenamenti, invece, sono simili a quelli che facevo in Italia. La preparazione è suddivisa in settori: si lavora sulla fase difensiva, offensiva, sui portieri, e tutto è curato nei minimi dettagli. L’approccio è molto professionale e ben strutturato, ma la parte fisica è considerata ancora più importante rispetto a quanto accade in Italia.”
È stato difficile ambientarti, sia calcisticamente che culturalmente, in una realtà così lontana dalla Sardegna?
“Non ho avuto molte difficoltà quando sono arrivato, a parte la lingua. Ero arrivato con una base, ma qui la gente parla un inglese con un accento diverso da quello che conoscevo. Dopo circa quattro mesi ho iniziato a parlarlo meglio e da allora continuo a migliorare. Essendo uscito di casa già a 14 anni, ero abituato a stare da solo, quindi l’adattamento non è stato un problema. Negli Stati Uniti c’è una cultura particolare, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli allenamenti e dello studio. Ci si allena tutti i giorni e l’aspetto fisico è considerato fondamentale. Spesso iniziamo la giornata in palestra alle 6 del mattino, facendo un’ora di esercizi, per poi andare a lezione. Anche il sistema educativo qui è molto diverso rispetto a quello italiano ed europeo. A parte qualche esame specifico, come “Public speaking”, non ci sono esami tradizionali. I docenti assegnano compiti ogni giorno e completandoli si accumulano punti. Se a fine anno raggiungi un certo numero di punti, passi automaticamente alla classe successiva. È un approccio totalmente diverso rispetto all’Europa, dove ci si concentra maggiormente sullo studio nozionistico. Qui invece il focus è più orientato verso la pratica e la preparazione per il mondo del lavoro, con un’enfasi particolare sull’aspetto business”.
Qual è stato il momento più difficile della tua carriera e come l’hai superato?
“Il momento più difficile della mia carriera è stato il secondo anno in Serie D, nell’autunno del 2022, dopo l’esperienza a Cagliari e la stagione precedente sempre al PDHAE. In quella fase avevo ricevuto alcune offerte, ma non sapevo mai se accettarle o se fidarmi. Mi ero affidato a un nuovo procuratore che, purtroppo, non mi ha aiutato come speravo, dopo aver lasciato il mio vecchio procuratore con cui avevo lavorato per quattro anni. Anche questo è stato un colpo duro, che mi ha portato a riflettere e a pensare di fermarmi un attimo per valutare meglio il mio futuro. A peggiorare la situazione è arrivato l’infortunio alla mano, che mi ha costretto a un’operazione e a restare fermo per mesi. È stato un periodo di grande confusione, perché a 21-22 anni senti il bisogno di trovare una certa stabilità. Quando sei più giovane, a 18-19 anni, sei disposto a girare l’Italia per cercare opportunità e anche noi sardi siamo abituati a farlo, dato che qui sull’isola le occasioni sono poche. Ci sono buone squadre, come per esempio il Latte Dolce o l’Atletico Uri, ma altre sono realtà in qualche modo limitate e spesso bisogna guardare altrove per crescere. Questa ricerca della stabilità, unita alle incertezze sulle scelte da fare e all’infortunio, ha reso quel periodo il più complicato della mia carriera. È stata una fase in cui ho davvero dovuto fermarmi, riflettere e cercare di ritrovare la strada giusta. Purtroppo, il mondo del calcio è molto difficile. Ho giocato con circa 500 ragazzi: di tutti loro solo uno è riuscito ad arrivare in Serie A”.
Che percorso di studi hai deciso di intraprendere e quanto è importante tenere la strada dello studio in parallelo alla carriera calcistica?
“In Italia giocare e studiare contemporaneamente è molto complicato, a meno che non ci si iscriva a un’università online, che però offre meno opportunità rispetto a quella tradizionale. In America invece è diverso: qui ti danno l’opportunità di vivere in campus enormi, dove tutto è a portata di mano. Sei a due minuti dalle aule e hai a disposizione strutture come palestra, campi da calcio, piscina e molto altro. Questo ti permette di avere una vita molto organizzata e veloce, senza spostamenti inutili e di concentrarti completamente su studio e sport, senza altre distrazioni. Per me continuare la carriera calcistica è fondamentale, perché è grazie a quella che posso essere qui. Senza il calcio, non potrei permettermi l’università, che costa dai 40 ai 50 mila euro all’anno. Grazie alla borsa di studio, invece, ho l’opportunità di studiare e formarmi. L’università, inoltre, offre molte possibilità di crescita personale e professionale: posso fare internship con agenzie e aziende americane, costruendomi un curriculum completo, sia a livello di esperienza lavorativa che di lingua e studi. Sto studiando “Sport Management”, perché mi piacerebbe rimanere nel mondo dello sport anche dopo la carriera da giocatore. Seguo tanti sport oltre al calcio, come il tennis, l’NBA, la pallavolo, e mi interessa approfondire la gestione e l’organizzazione legate a questo settore”.
Consiglieresti questa esperienza ad altri giovani calciatori e non?
“Per quanto riguarda l’eleggibilità sportiva per il college, hai a disposizione quattro anni per giocare, quindi se sei troppo grande può diventare difficile entrare. Chiaramente, arrivare a 25-26-27 anni rende la cosa molto complicata. Tuttavia, esistono altre opportunità per giocare negli Stati Uniti come italiano, anche senza passare dal college. Una di queste è partecipare ai campionati estivi, che durano tre mesi. Questi tornei possono offrire grande visibilità, specialmente a un italiano talentuoso nel calcio. È un’esperienza che consiglio ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Se si ha il coraggio di intraprendere un’avventura diversa, è un’esperienza che rimane per tutta la vita. Si tratta di un ambiente molto genuino, con poca gelosia, e soprattutto estremamente meritocratico: se sei bravo, giochi. E se notano il tuo talento, ti aiutano a progredire”.
Progetti per il futuro?
“Attualmente il mio obiettivo principale è laurearmi. Rimarrò in Missouri fino a maggio, poi vedremo cosa riserva il futuro. Sto valutando alcune offerte e proposte calcistiche da diverse università e potrei trasferirmi in una zona più calda, magari simile alla costa di Baunei, che da sardo mi ricorda casa. Dopo la laurea, la situazione sarà più complessa. La mia famiglia è tutta in Italia, quindi decidere di restare a lungo termine in America per lavorare non è una scelta facile. Tuttavia, questa esperienza potrebbe aprirmi nuove strade anche in Europa. La vita è imprevedibile, e potrei cambiare idea da un momento all’altro. L’importante per me è mantenere sempre diverse opzioni aperte”.
Ti manca la Sardegna?
“Mi manca comunque la qualità della vita che si ha in Sardegna, una cosa che non si può trovare facilmente altrove. La mia famiglia è in Italia e quando torno è sempre un’emozione unica. Il sardo, ovunque si trovi – che sia a Roma, a New York o anche in Antartide – è sempre molto legato alla propria terra, più patriottico che mai. Anche quando devo fare delle foto qui al campus, porto sempre con me la bandiera della Sardegna. Il mio accento è un po’ più neutro, perché ho vissuto tanti anni fuori, ma dentro di me la Sardegna è sempre presente. Torno nell’Isola ogni estate, sono profondamente legato alle mie radici e queste resteranno sempre una parte di me. Chissà, magari in futuro deciderò di lavorare proprio qui, in Sardegna”.
C’è qualcosa che vorresti aggiungere come riflessione finale?
“Sarò sempre grato al Cagliari per l’opportunità che mi ha dato. Sono arrivato da un paesino di 3.000 abitanti e il Cagliari è stato quello che mi ha fatto partire nella mia carriera. Questo lo riconoscerò sempre. Anche se le cose non sono finite nel migliore dei modi, il mio sarà per sempre un grazie. Lo stesso vale per l’Adriese e il PDHAE, non dimentico mai chi mi ha dato una mano, non sputo mai nel piatto in cui ho mangiato. Un’ultima cosa che ci tengo a dire: per qualsiasi ragazzo sardo che ha intenzione di cogliere questa opportunità, se c’è qualcuno che vuole partire, io posso dare tante informazioni attraverso la mia agenzia. Posso aiutare a capire meglio come funziona, perché spesso su internet non si trovano tutte le informazioni necessarie. Avere qualcuno che ti dà il suo punto di vista e ti fa da tramite è davvero molto utile”.
Matteo Cubadda